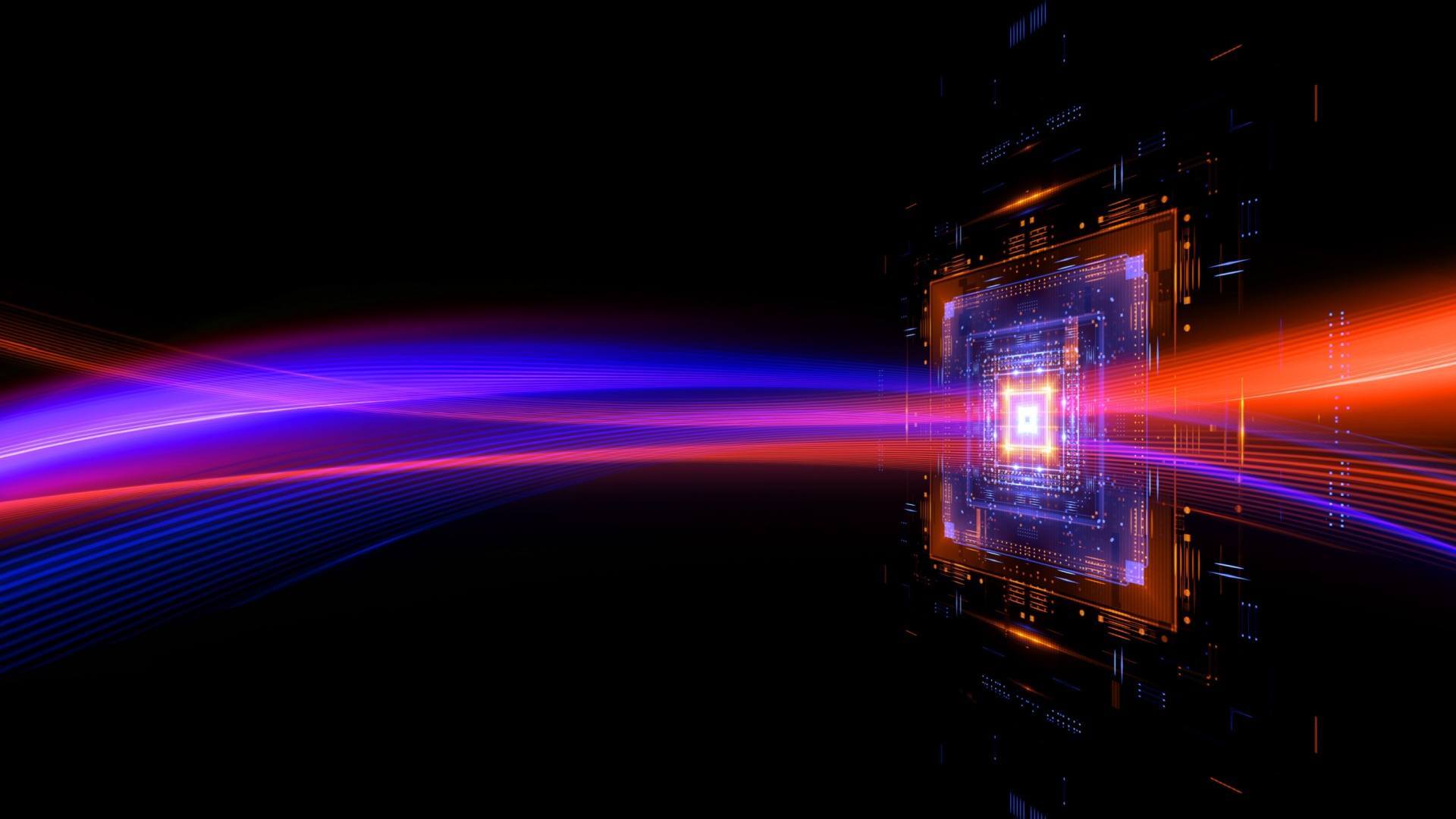Apple e Google sono stati duri sul Digital Markets Act nei giorni scorsi con la Commissione Ue.
Secondo loro la normativa europea determinerebbe un peggioramento dell’esperienza degli utenti, con ritardi nell’introduzione delle innovazioni, accresciuti rischi per la sicurezza e una generale perdita di qualità.
Queste posizioni sono un esempio emblematico di come le grandi piattaforme cerchino di trasformare una disciplina di regolazione della concorrenza in un presunto ostacolo al progresso – si colloca in un passaggio cruciale della politica europea del digitale, poiché non si limita a segnalare difficoltà applicative ma assume i toni di una critica sistemica all’impianto normativo dell’Unione.
Infatti, attribuire alla legge la colpa di un presunto arretramento tecnologico, con ritardi nello sviluppo delle funzionalità, con rischi crescenti per la sicurezza e con un impoverimento dell’esperienza degli utenti, significa infatti spostare il dibattito dal terreno tecnico a quello politico e simbolico, ponendo l’Unione nel ruolo di ostacolo al progresso e la piattaforma globale nel ruolo di sua paladina.
Il DMA “non è mai stato concepito per peggiorare l’esperienza degli utenti, ma per ampliarne le scelte, garantire equità e stimolare innovazione”, spiega, sentito da AgendaDigitale, l’onorevole Sandro Gozi, voce autorevole nel dibattito sulla sovranità digitale europea, aggiungendo che l’interoperabilità serve “a superare i silos chiusi e a dare più libertà alle persone, senza sacrificare sicurezza e privacy”, smontando così alla radice quella figura retorica del capro espiatorio con cui si vorrebbe imputare alla legge ogni ritardo o frizione.
Indice degli argomenti
Il nodo del DMA per le big tech
Il cuore della controversia, infatti, non è se una specifica funzione – la traduzione in tempo reale, il mirroring, la conservazione locale di percorsi – richieda più tempo per essere resa compatibile con interfacce esterne, ma se la “sicurezza” possa essere brandita come scudo semantico per neutralizzare una politica della concorrenza che intende impedire ai guardiani dell’accesso di trasformarsi in cancelli invalicabili.
Quando Apple afferma che l’obbligo di aprire canali di distribuzione, sistemi di pagamento e componenti essenziali accrescerebbe i rischi per gli utenti, propone una scelta binaria e falsante che ignora la storia tecnica di Internet, fatta di standard aperti, verifica pubblica, responsabilizzazione degli attori e livelli di protezione che si costruiscono per progettazione e certificazione, non per clausura proprietaria.
Non a caso Gozi qualifica quella posizione per ciò che è, “non una difesa della sicurezza, ma la difesa di una sovranità tecnologica privata, in cui il potere resta nelle mani delle piattaforme”, e richiama l’alternativa che l’Europa ha già scelto: “La sovranità digitale appartiene al pubblico, e viene esercitata con regole democraticamente adottate”, dunque interoperabilità e tutela dei dati non sono antinomiche, ma concetti da armonizzare in un quadro di responsabilità condivise e controllabili.
Anche Google ha fatto pervenire alla Commissione europea il proprio contributo scritto nell’ambito della consultazione pubblica avviata a inizio luglio sul Digital Markets Act (DMA). Analogamente ad Apple, ma con toni meno polemici, l’azienda di Mountain View ha chiesto un sostanziale “reset” della normativa, sostenendo che la sua applicazione comporti più effetti negativi che benefici.
Secondo Google, il DMA – nato per limitare il potere dei grandi gatekeeper digitali e rafforzare la concorrenza – avrebbe finora ridotto le possibilità di scelta per gli utenti, minato alcuni standard di sicurezza e reso più complesso l’ecosistema competitivo europeo. L’azienda teme che le nuove regole, invece di aprire il mercato, possano consolidare posizioni di rendita per attori minori senza garantire reali vantaggi a consumatori e sviluppatori.
Sul piano giuridico la contro-narrazione dell’arbitrarietà dell’enforcement merita di essere ricondotta al suo perimetro: le obbligazioni del DMA non nascono da un’improvvisazione punitiva, ma da presupposti tipizzati – posizione di gatekeeper, effetti sul mercato interno, pratiche di auto-preferenza e di chiusura dell’accesso – e si applicano secondo un principio di proporzionalità funzionale all’obiettivo di ripristinare contendibilità degli ecosistemi; per questo l’onorevole afferma che “le regole del DMA non sono arbitrarie: si applicano in modo mirato e proporzionato ai gatekeeper, sulla base di criteri oggettivi”, e che definire “dannosi” tali obblighi “è il classico schema di lobbying, volto a ottenere deroghe e rinvii”.
Il punto è essenziale: quando la comunicazione d’impresa trasforma l’inevitabile costo di adeguamento in un preteso vulnus per gli utenti, cerca di traslare sul terreno emotivo una questione di giustizia concorrenziale, invocando l’argomento tecnico per ottenere uno sconto politico, ma la tecnica, in un ordinamento democratico, non sostituisce il diritto, lo attua e se l’adeguamento richiede ingegneria aggiuntiva, il tempo della complessità non muta la natura del dovere, perché l’alternativa sarebbe ammettere che la difficoltà di aprire un’interfaccia possa legittimare la permanenza di una rendita.
La prospettiva strategica nel rapporto tra big tech e Dma
Vi è poi la dimensione strategica del rischio di annacquamento, che Gozi esplicita senza giri di parole: “Se l’Europa accettasse deroghe o interpretazioni flessibili, minerebbe la propria credibilità come regolatore globale”; l’avvertimento è pregnante perché coglie il nesso tra coerenza normativa e potere di proiezione: dopo aver edificato un corpus che va dal regolamento generale sulla protezione dei dati al pacchetto dei servizi e dell’intelligenza artificiale, l’Unione non può concedersi il lusso dell’incoerenza, pena il messaggio più dannoso che si possa inviare ai mercati e ai cittadini.
Ossia che le regole valgono finché non toccano interessi sufficientemente forti; l’effetto non sarebbe solo una perdita di efficacia antimonopolistica, ma un indebolimento della stessa idea di sovranità, perché accettare che un’impresa globale detti i confini della propria conformità equivale a riconoscerle un potere normativo di fatto e la sovranità, al contrario, si afferma con norme chiare e con un’applicazione imparziale, capace di sanzioni proporzionate ma esemplari e con la costruzione di strumenti tecnici che traducano i principi in pratiche verificabili, così da sottrarre l’enforcement all’accusa di arbitrarietà.
A questo dispositivo giuridico deve affiancarsi, come ricorda l’europarlamentare, una politica della parola pubblica è “evidente che Apple prova a combattere la sua battaglia sul terreno della comunicazione, dipingendo sé stessa come difensore dei consumatori e l’Europa come freno al progresso”, e per questo “serve una vera strategia comunicativa europea, coordinata tra istituzioni, autorità nazionali e società civile, che parli ai cittadini in modo diretto e semplice”.
Qui si apre una responsabilità specifica: spiegare che l’apertura a canali di distribuzione alternativi non significa resa all’illecito, perché l’ordinamento conserva strumenti di responsabilità, tracciabilità e rimozione; chiarire che l’accesso a tecnologie di base non coincide con l’esproprio dell’ingegno, bensì con la prevenzione di effetti di chiusura che impediscono a imprese e sviluppatori di competere sul merito, ricordare che la differenziazione di un prodotto non può consistere nell’impossibilità di abbandonarlo senza costi abnormi di transizione, giacché la libertà di scelta presuppone reale portabilità e assenza di vincoli artificiosi.
Le priorità da affrontare
Da ciò discende l’esigenza di una comunicazione istituzionale che non si limiti a confutare slogan, ma renda intellegibili i meccanismi concreti con cui la legge tutela la sicurezza dentro l’apertura, come illustrare quali controlli siano imposti ai mercati alternativi delle applicazioni, quali requisiti di qualità e di informazione gravino su chi offre pagamenti diversi, quali obblighi di segnalazione e rimozione scattino in presenza di contenuti o software nocivi, quali strumenti di rimedio e di restituzione siano a disposizione dell’utente – e, per converso, pretendere che chi invoca rischi indeterminati li specifichi, li quantifichi, li documenti, assumendosi un onere argomentativo rafforzato quando chiede deroghe alla regola dell’interoperabilità.
Quindi, una strategia della parola pubblica, in questa materia, significa anche rendere tracciabile la catena delle decisioni: pubblicare linee interpretative chiare, riferire periodicamente sull’impatto delle misure, istituire registri accessibili delle richieste di accesso alle interfacce essenziali e delle eventuali eccezioni concesse, così che la cittadinanza possa vedere come il principio si traduce in pratica e come sono valutati i bilanciamenti tra innovazione, concorrenza e tutela dei dati.
È in questo spazio di chiarificazione che la narrazione della “sicurezza come sinonimo di chiusura” perde presa, perché viene mostrato che la sicurezza è il risultato di regole verificabili, di certificazioni tecniche, di responsabilità effettive e di rimedi esigibili, non di una sovranità privata che chiede fiducia in assenza di controllo e che la vera protezione dell’utente non è l’eterna permanenza nel recinto, ma la possibilità di scegliere consapevolmente, di migrare senza danno, di conoscere chi risponde in caso di abuso.
In controluce, il comunicato aziendale elenca una casistica di rischi (dal presunto aumento di esposizione a contenuti dannosi fino alla richiesta di dati sensibili come notifiche o cronologie di rete) per suggerire che l’apertura imposta dalla legge spalanchi le porte a un far-west digitale; ma il ragionamento confonde i piani: l’ordine pubblico della rete non si realizza per grazia di un giardino chiuso, si realizza con regole generali che assicurano responsabilità, controlli e sanzioni; se talune richieste di accesso a componenti o a dati appaiono eccedenti, il luogo della contestazione è il procedimento amministrativo e, in ultima istanza, il giudice, non il veto privato che pretende di farsi norma.
La sovranità tecnologica privata
Diversamente si legittimerebbe quella “sovranità tecnologica privata” che Gozi denuncia e che consiste nell’attribuire all’architettura proprietaria la funzione di fonte: è la piattaforma a decidere che cosa è consentito, in virtù di un presunto primato etico della propria sicurezza; ma proprio l’Europa, attraverso regole come il DMA, afferma l’opposto: la sicurezza è un bene pubblico e si costruisce anche imponendo aperture governate, audit di terze parti, obblighi di documentazione e cooperazione, nonché percorsi di conformità che consentano innovazione senza subordinare l’interesse generale alla discrezionalità di un ecosistema.
Il punto di caduta, allora, è meno tecnico di quanto appaia e più politico-giuridico: decidere se accettiamo che la narrazione di un attore dominante riduca il dibattito alla contrapposizione fra tutela e progresso, quando la funzione della legge è precisamente rompere questo falso dilemma; in questa prospettiva, le parole dell’onorevole – “il vero rischio di annacquare il DMA esiste solo se accettiamo la narrazione costruita da chi mira a perpetuare il proprio monopolio” – valgono da bussola: non si tratta di negare le complessità dell’implementazione, ma di rifiutare che la complessità diventi il grimaldello per sospendere indefinitamente la concorrenza e non si tratta di opporre ideologicamente pubblico e privato, ma di riportare l’impresa al suo ruolo naturale, potentissimo ma non sovrano, dentro una cornice di responsabilità stabilita dalla legge, solo così la promessa europea potrà resistere alla tentazione di arretrare di fronte alla forza persuasiva del racconto ed è in questa fedeltà a sé che la sovranità digitale smette di essere slogan e diventa pratica.
La capacità di dire che cosa è lecito nell’interesse di tutti, anche quando questo significa pretendere dai campioni globali ciò che chiediamo a chiunque altro, ossia apertura ragionevole, trasparenza delle interfacce, rispetto di standard condivisi e disponibilità a essere valutati da autorità indipendenti – perché, se c’è un messaggio che l’Europa non può permettersi di inviare, è che le sue regole valgono meno della paura di perdere una funzione nuova sullo schermo: le funzioni passano, gli ordinamenti restano.