La manifattura italiana non è un capitolo del passato: è, al momento, il pezzo più concreto del nostro futuro. È la spina dorsale che tiene insieme salari, export, ricerca applicata, filiere territoriali e competenze tecniche che non si improvvisano, insieme a una cultura del “fare bene” che, quando funziona, diventa reputazione del Paese.
approfondimento
Manifattura italiana, perché il 2026 è l’anno della fabbrica cognitiva
La manifattura resta l’asse del Made in Italy: tiene insieme salari, export, ricerca applicata e filiere. Ma tra energia instabile, supply chain fragili e nuova concorrenza, l’eccellenza non basta. Serve un salto organizzativo e digitale per non ridursi a un’etichetta senza fabbrica
Base Italia
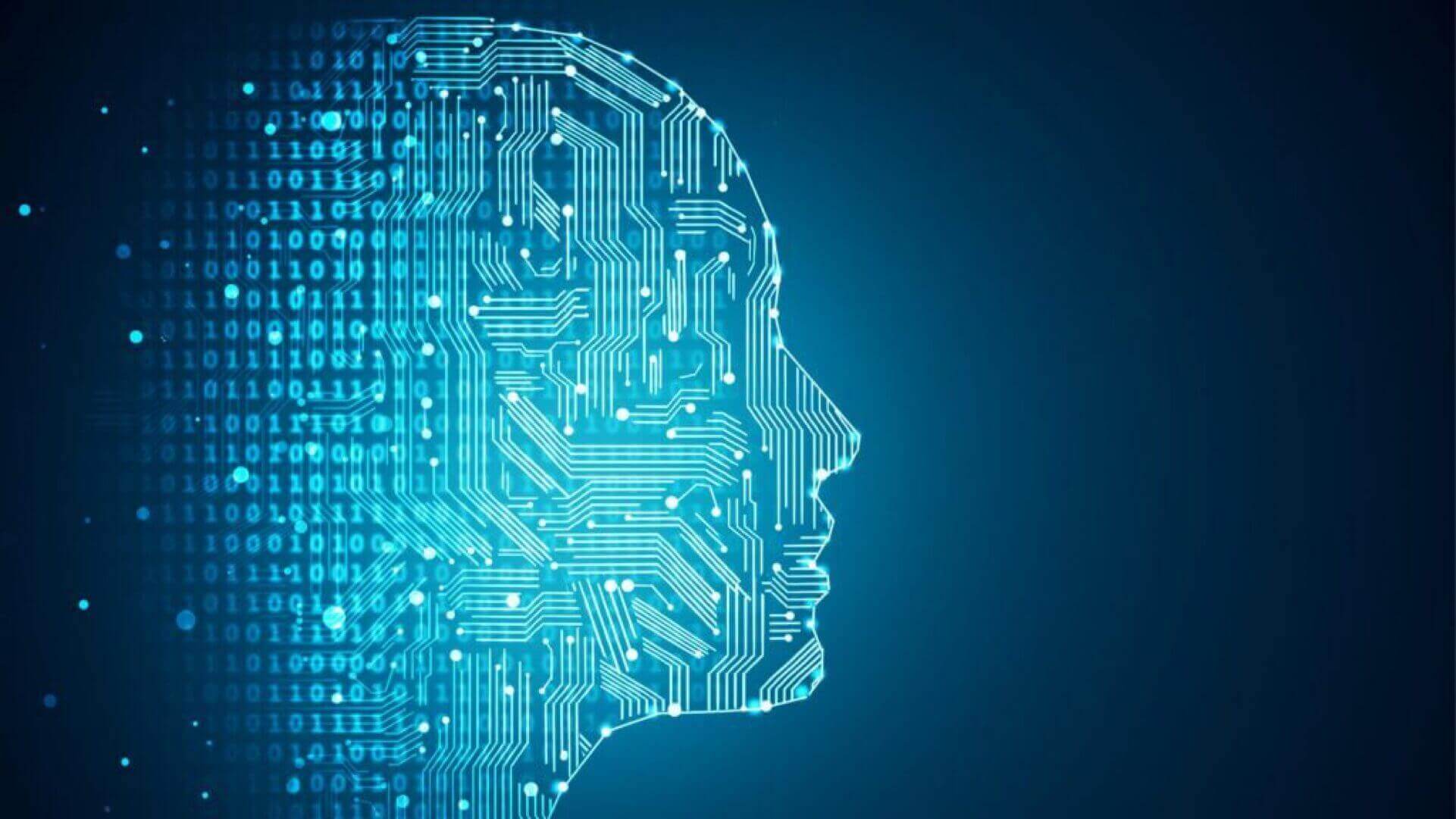
Continua a leggere questo articolo
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business

InnovAttori
-

Robotica avanzata: la strategia italiana per competere con Cina e Usa
24 Feb 2026 -

Industria metalmeccanica, se il consulente è la GenAI: il caso Co.Me.T
24 Feb 2026 -

L’AI cambia la fabbrica: ecco i trend più avanzati
23 Feb 2026 -

San Raffaele, l’AI entra nella pratica clinica: meno burocrazia, più ascolto
23 Feb 2026 -

L’IA alleata degli chef: così aiuta a innovare e a sprecare meno
19 Feb 2026

















