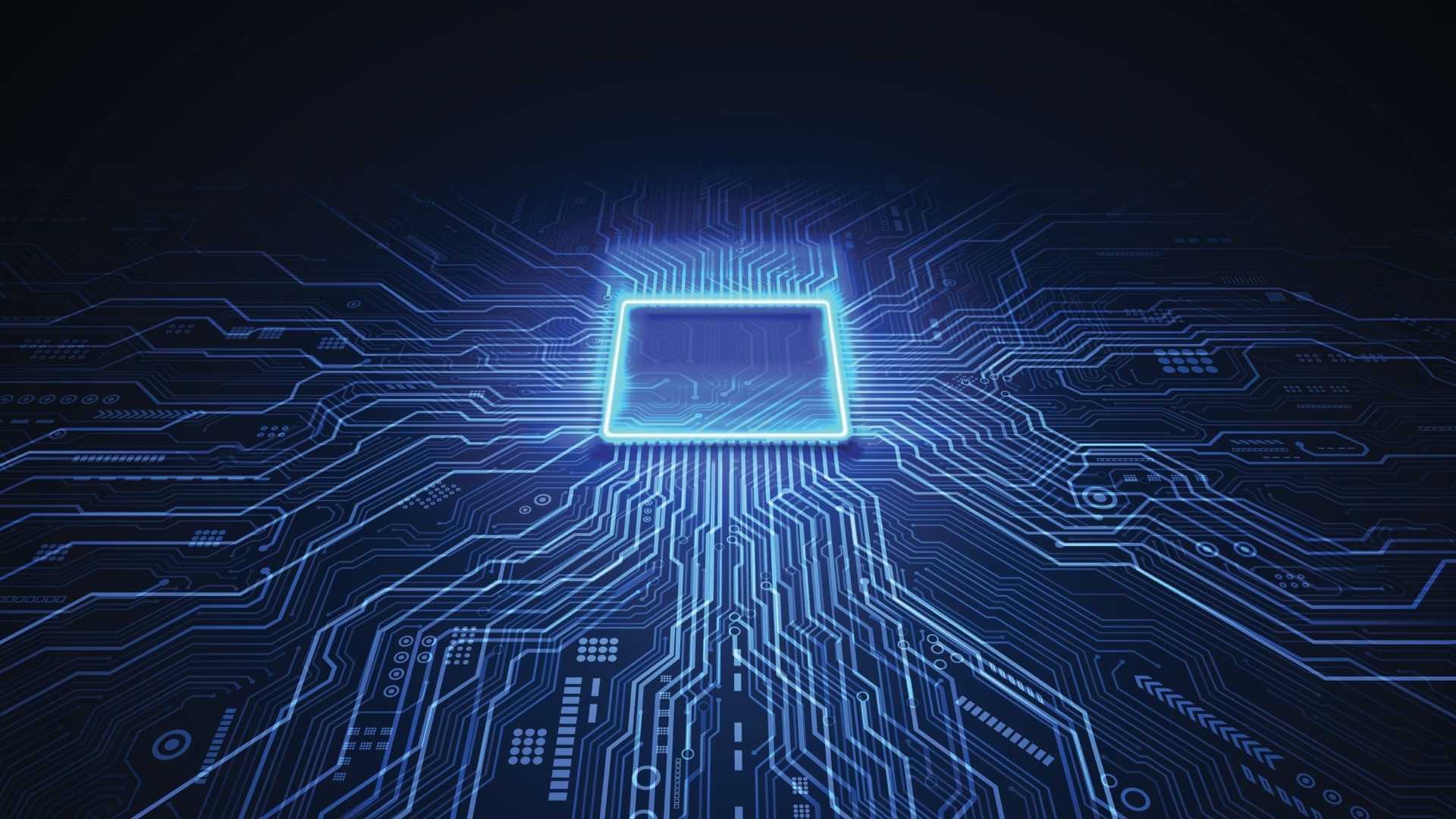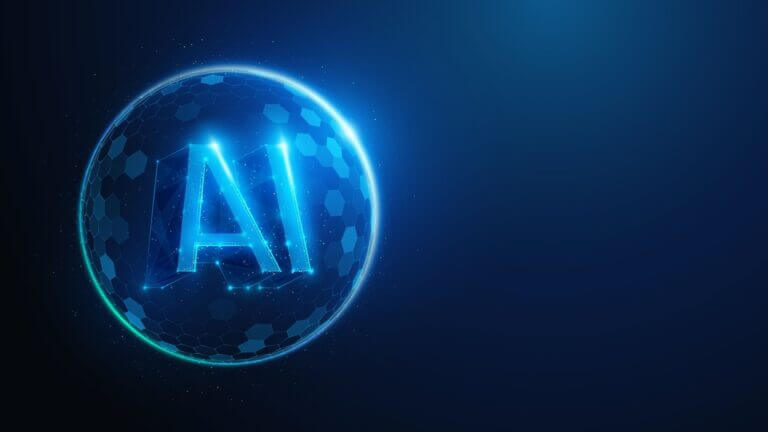La spinta a rendere disponibili ai cittadini e alle imprese i dati generati dalle pubbliche amministrazioni ha visto una forte accelerazione negli ultimi 15 anni. Essa ha attivato un network normativo, tecnico e istituzionale che ha costretto, ma ha anche aiutato, gli enti pubblici a condividere pubblicamente i propri dati legati alle diverse sfere di vita dei cittadini. Oltre alla creazione di valore economico, l’obiettivo forse più alto di questo ampio, e non sempre indolore, processo è quanto mai sfidante: riavvicinare i cittadini alle istituzioni, recuperare un legame fiduciario, oggi incrinato, attraverso la trasparenza e la partecipazione. Un’applicazione degli open data che più delle altre incarna questo ideale è quella del monitoraggio civico, che si concretizza nel controllo dell’ente pubblico da parte della società civile attraverso l’uso dei dati da esso stesso prodotti.
Tra i vari ambiti coperti dagli open data, questa progressiva disclosure ha consegnato alla collettività una vastissima mole di informazioni legate agli appalti pubblici nazionali e locali: il public procurement – così viene tecnicamente chiamato il processo di affidamento di risorse pubbliche a soggetti terzi per lavori, servizi o forniture – in Italia mobilita oggi oltre il 16% del Pil e gioca un ruolo fondamentale nella gestione di infrastrutture e servizi territoriali, con impatto diretto e concreto sulla vita quotidiana dei cittadini.
Indice degli argomenti
Il rapporto tra open data e public procurement
L’ANAC, Autorità Nazionale Anti-Corruzione, censisce questo fenomeno da oltre vent’anni (con una copertura particolarmente elevata a partire dal 2010) e ne pubblica da tempo i dati completi e standardizzati sul proprio portale aperto. Si tratta di una mole di informazioni enorme suddivisa in oltre 240 files, ma che è in grado di restituire un’immagine granulare degli appalti italiani e del loro recente percorso evolutivo.
Al di là della disponibilità di dati, gli appalti costituiscono però un fenomeno complesso e comprenderli significa scontrarsi con barriere di carattere tecnico e giuridico che potrebbero dissuadere il cittadino che volesse capirci di più.
Nell’ambito del Progetto d’Eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca, dedicato proprio agli Open Government Data, una specifica linea di ricerca sta studiando il public procurement comunale, con l’obiettivo di comprenderne l’evoluzione e le peculiarità in termini di mutamento organizzativo [1].
I nodi degli appalti pubblici
Per chi vive in Itala il concetto di appalto pubblico assume spesso connotazione negativa e denotazione sfumata. Connotazione negativa perché l’attività di assegnazione di fondi attraverso gare a evidenza pubblica (o altre procedure di aggiudicazione) sale di solito alle cronache quando qualcosa va storto: episodi corruttivi e tangenti in fase di assegnazione, malversazione, tempistiche dilatate, errori di implementazione od opere incompiute. Spesso inoltre questo concetto viene sovrapposto a quello di privatizzazione, o comunque associato all’idea di drenaggio, spesso clientelare, di denaro pubblico nelle tasche di privati. Un po’ come con le tasse – seppure linfa vitale del servizio pubblico – neanche parlando di appalti è facile accendere l’entusiasmo e il senso di comunità tra i cittadini. Denotazione sfumata perché degli appalti si sa poco: finché va tutto bene non se ne parla, le procedure a essi soggiacenti sono complesse e infarcite di tecnicismi, le normative evolvono rapidamente. A meno che non si operi entro la sua stessa filiera, questo fenomeno rimane carsico e riaffiora in superfice soltanto sulle colonne della cronaca giudiziaria o tra le ruspe nei cantieri urbani che, si sa, durano troppo e si sarebbero sempre e comunque potuti gestire meglio.
Il senso comune è del resto uno strumento essenziale per muoverci nella realtà quotidiana senza esserne sopraffatti. In quanto tale esso è radicato nella realtà e da essa assume informazioni selettivamente per darci un’idea dei fenomeni che ci circondano, senza sottrarre troppa attenzione ed energie alle nostre attività principali. In questo senso la comune rappresentazione degli appalti parte, anch’essa selettivamente, da alcuni elementi di realtà: tra i Paesi industrializzati l’Italia esprime livelli di corruzione elevati, tempi della giustizia lunghi e incerti, così come un sovraccarico burocratico diffuso, che gli studiosi di pubblica amministrazione chiamano red tape (come il nastro rosso usato per avvolgere i corposi ed emblematici “faldoni” che arredavano gli uffici pubblici prima della svolta digitale).
Se da un lato gli appalti costituiscono la cartina tornasole (o il parafulmine) di questa situazione, dall’altro pochi hanno chiaro quale sia l’effettivo ruolo che essi giocano nell’economia, così come quale possa essere il loro impatto sulla propria quotidianità e sul proprio territorio.
Cosa dicono i dati di ANAC
Alcuni numeri ci aiutano a comprendere meglio la portata del fenomeno. Secondo i dati dell’ANAC, nel solo 2023 le pubbliche amministrazioni centrali e locali italiane (Ministeri, Regioni, Comuni ecc.) hanno bandito commesse per oltre 376 miliardi di euro, un valore pari al 16% del Pil. Questo rapporto è simile anche negli altri Paesi europei e nel resto della galassia OCSE, dove si aggira intorno al 14%. Un crescente corpus di studi ha inoltre mostrato come, a determinate condizioni, il meccanismo dell’appalto possa costituire un propulsore alla specializzazione, allo sviluppo di servizi di qualità, all’innovazione, fino alla promozione della sostenibilità nel mercato.
Se dei grandi appalti nazionali può risultare a volte più complesso venire a capo, un ottimo punto di partenza per il cittadino che volesse approfondire il fenomeno possono essere quelli comunali. Sempre nel 2023 i Comuni italiani hanno infatti bandito oltre 68 miliardi di euro (pari al 3.8% del Pil) attraverso quasi 2 milioni di procedure. Ciò significa che a livello locale il cittadino è letteralmente immerso nelle opere e nei servizi gestiti in appalto: dalle strade che percorre ai rifiuti che conferisce, dall’acqua che beve al pranzo che consuma a scuola, da quando accende una lampadina fino a quando entra in un museo o riceve a casa un assistente domiciliare. Gli appalti comunali non riguardano infatti solo i lavori di costruzione che assorbono circa il 45% del procurement comunale, ma anche la gestione di servizi (43%) e l’acquisto delle forniture (12%) necessarie al funzionamento dell’ente pubblico e dei suoi servizi.
Ruolo e forma dei Comuni
Con le politiche di decentramento e deregulation poste in essere in Italia a partire dagli anni ’90, i Comuni italiani hanno visto accresciuta, volenti o nolenti, la propria centralità nella gestione delle infrastrutture e dei servizi locali. Nello stesso periodo, sospinta della mentalità aziendale di fine secolo, ha conosciuto crescente diffusione la pratica del contracting out, ovvero il passaggio di una serie di attività e funzioni in precedenza gestite dal pubblico verso fornitori privati (o pubblico-privati) tramite procedura di affidamento. Contemporaneamente, ad affollare ulteriormente lo scenario, sono proliferati enti e società partecipate (parzialmente o interamente, direttamente o indirettamente) dai Comuni, per cui l’aggettivo “comunale” sempre più spesso oggi indica uno fitto network di soggetti pubblici e privati piuttosto che un singolo municipio.
Va poi considerata la frammentazione demografica di questi enti locali – in oltre 9 casi su 10 ospitano meno di 5.000 residenti – che, se non gestita, porta con sé difficoltà organizzative e finanziarie che ne riducono la possibilità di investire, di erogare servizi specializzati, ma anche di dotarsi di personale numericamente congruo e adeguatamente qualificato. Ecco allora che la cooperazione tra più Comuni attraverso l’esercizio associato, la creazione di enti intercomunali (come Centrali d’Acquisto, Unioni di Comuni e Comunità montane o aziende speciali) o la fondazione di società in-house providing, è divenuta per molti un passaggio obbligato verso la specializzazione e la promozione di economie di scala.
Appalti comunali: un fenomeno in crescita
Dopo una fase di contrazione dei finanziamenti locali, dovuta alle politiche di austerità e ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno, l’ultimo decennio ha visto un rinnovato protagonismo dei Comuni. Grazie a una serie di normative nazionali e comunitarie, essi si sono trovati a gestire ingenti risorse, investiti del compito, tra gli altri, di colmare il deficit infrastrutturale accumulato sui territori. In questo senso, il PNRR non ha fatto che accelerare tale dinamica.
L’analisi degli open data dell’ANAC fornisce infatti innanzitutto evidenza puntuale della costante crescita del public procurement comunale italiano: dai 37 miliardi di euro banditi nel 2015 si è giunti a oltre 68 nel 2023, con un incremento particolarmente marcato nel settore dei lavori infrastrutturali, ma anche nei servizi e nelle forniture durante il periodo pandemico. Vale la pena sottolineare che si tratta di una crescita continua che, anche calcolata al netto dell’inflazione e dei fondi PNRR, rimane significativa: +27% in nove anni.
In secondo luogo, i dati mostrano una progressiva centralizzazione degli appalti comunali: a fronte di un calo limitato del numero delle stazioni appaltanti, si registra un aumento consistente degli importi medi banditi annualmente da ciascuna di esse. Nel 2015 le stazioni appaltanti comunali erano oltre 9.500, un numero poi calato del 3% in nove anni. Se è lecito chiedersi com’è che, a fronte di circa 7.900 Comuni italiani, possano esistere oltre 9.000 stazioni appaltanti, la spiegazione risiede nel fatto che i Comuni delegano in modo crescente, seppure in specifiche circostanze, la stessa gestione degli appalti alle società in-house e agli enti intercomunali che controllano. Così ad esempio nel 2023 hanno bandito fondi comunali 7.800 comuni, 591 società in-house e 882 enti intercomunali. Ed è proprio da qui che emerge più chiaramente il processo di centralizzazione: sia i singoli Comuni, sia – soprattutto – queste altre realtà delegate, gestiscono ogni anno una quota sempre più elevata di fondi pubblici da affidare tramite gara.
Il potere e i limiti degli open data
ùQueste sono solo alcune prime evidenze, portate a esempio, della nostra analisi dei dati sugli appalti comunali italiani. Esse sono tuttavia già utili a indirizzare lo sguardo verso un mutamento organizzativo non dirompente, ma che, in linea con lo stile cauto della pubblica amministrazione italiana, parrebbe spostarsi gradualmente (e non senza differenze locali) verso una crescente specializzazione e una maggiore flessibilità, centralizzando progressivamente la spesa su un numero più contenuto di stazioni appaltanti qualificate – come del resto indicato dallo stesso Codice degli appalti. D’altra parte, come in tutti i casi nei quali la gestione finanziaria si concentri in un numero di mani minore, ciò lascia intravedere la necessità di riflettere circa la capacità dei Comuni italiani di esercitare il proprio ruolo strategico e di controllo (spesso congiunto) sia sulle stazioni appaltanti delegate sia sugli aggiudicatari dei bandi, così come di valutare se e in quale misura questo processo incida virtuosamente sull’esito dell’opera, del servizio o della fornitura appaltati.
Gli open data sugli appalti dell’ANAC – grazie anche al crescente livello di integrazione con le altre banche dati nazionali sugli investimenti pubblici, come OPENCUP e OPENBDAP, insieme alle fonti comunitarie – costituiscono una base dati enorme, di qualità e con buoni livelli di copertura, che impone però all’utente una soglia di accesso tecnico e giuridico-amministrativa molto elevata. Se le imprese e l’accademia, così come il vitale associazionismo legato agli open data si stanno attrezzando e cooperando per affrontare questa sfida, il cittadino rimane ancora ai margini. E così che l’Umarell – quell’omino anziano che osserva i cantieri dispensando consigli, che pare ormai essere stato avvistato in tutto il Paese – rimane a oggi ancora il principale baluardo del monitoraggio civico in fatto di appalti locali.
Bibliografia
Baldi S., Bottasso A., Conti M. e C. Piccardo (2016), To bid or not to bid: That is the question: Public procurement, project complexity and corruption, in European Journal of Political Economy, vol.43/2016, pp.89-106, Elsevier Inc., London.
Bosio E., Djankov S., Glaeser E. e A. Shleifer (2022), Public Procurement in Law and Practice, American Economic Review, vol.112 (4)/2022, pp.1091-1117, American Economic Association, Nashville (USA).
Cavallini I. (2023), La gestione delle società a partecipazione pubblica, Giappichelli Editore, Torino (IT).
Citroni G., Lippi A. e S. Profeti (2013), Ramapping the State: Inter-Municipal Cooperation through Corporatisation and Public-Private Governance Structures, in Local Government Studies, vol.39 n.2, pp.208-234, Taylor and Francis, Milton Park.
Crouch C. (2004), Post democracy, Wiley, Hoboken.
De Carolis F. (2014), Awarding Price, Contract Performance, and Bids Creening: Evidence from Procurement Auctions, American Economic Journal: Applied Economics, vol.6/2014, pp.108-132, Benjamin Olken, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
Fazekas M., Nishchal S. e T. Soreide (2025), The Impact of Emergencies on Corruption Risks: Italian Natural Disasters and Public Procurement, in Regulation & Governance, vol.1/2025.
Fazekas M. (2017), Assessing The Quality Of Government At The Regional Level Using Public Procurement Data, Working Papers, vol.12/2017, European Commission, Luxemburg.
Gao, Y., Janssen M. e C. Zhang (2023), Understanding the evolution of open government data research: towards open data sustainablity and smartness, in International Review of Administrative Sciences, vol.89, pp.59-75, Sage Publications, Thousand Oaks.
Grimshaw D., Vincent S. e Willmott H. (2002), Going Privately: Partnership and Outsourcing in UK Public Services, Public Administration, vol.80 n.3, pp.475-502, Blackwell Publishers Ltd, Oxford and Malden.
Johansson T. (2015), A critical appraisal of the current use of transaction cost explanations for government make-or-buy choices. Towards a contingent theory and forms of tests, In Public Management Review, vol.17 n.3, pp.661-678, Routledge, London.
Morgan C., e R. Sonnino (2007), Empowering consumers: the creative procurement of school meals in Italy and the UK, in International Journal of Consumer Studies, vol.31/2007, pp.19-25, Blackwell Publishers Ltd, Oxford and Malden.
Rota F. (2016), Qualità e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici fra concorrenza e buon andamento, in Amministrativamente, vol.9-10/2016, pp.1-18, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Roma.
Zuffada E. e E. Caperchione (2003), The inter-related roles of the regional and local government in developing local partnerships in Italy, SDA Bocconi, Milano.
[1] Progetto d’Eccellenza “OPEN GOVERNMENT DATA. Conoscere la società attraverso i dati della Pubblica Amministrazione”, finanziamento MUR 2023–2027, Nota 15659 del 28/12/2022