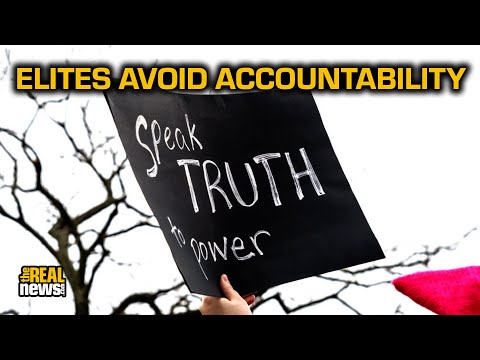Nel discorso pubblico si fa spesso riferimento alla cancel culture come una forma di ideologia politica – una sorta di esasperazione violenta di progressismo – promossa dalle nuove generazioni nei confronti di figure o testi ritenuti problematici indipendentemente dalla loro collocazione temporale, sia che si tratti di personaggi del mondo dello spettacolo a noi contemporanei, o opere d’arte appartenenti a diversi periodi storici.
Ma la cancel culture non è un’ideologia, bensì si riferisce a discorsi associati a pratiche, call-out e canceling, da contestualizzare nell’ambito delle comunità online. Un’ipotesi critica aiuta a comprendere il travisamento di un’espressione. Ecco come è possibile capire la cancel culture con la semiotica.
La disambiguazione di cancel culture
Proviamo a proporre una disambiguazione del significante “cancel culture” attraverso la contestualizzazione di diverse pratiche – specialmente quelle del call-out e del canceling – nate all’interno di comunità online, intorno a specifiche condizioni e avvenimenti di interesse sociale, politico e culturale. In questa maniera, proviamo a spiegare come sia possibile descrivere, comprendere e spiegare il discorso sulla cancel culture, così come le pratiche ad esso associate, in termini semiotici, e nello specifico nei termini di una descrizione dei codici delle subculture digitali che abitano determinati spazi online.
Attraverso una prospettiva transmediale [1] – che osserva una circolarità tra i cosiddetti media tradizionali, come i quotidiani di informazione, ed i media digitali –, si potrà far emergere come questi ambienti, pur non costituendosi come luoghi altri rispetto al discorso pubblico o alla vita offline, siano caratterizzati da codici e linguaggi specifici, e come nella migrazione di questi ultimi da un ambiente mediale ad un altro possano avvenire delle traduzioni non sempre fedeli ai contesti di emergenza.
In principio fu il #gamergate
Per proporre una contestualizzazione mediale del fenomeno culturale delle pratiche di canceling – e come si è arrivati a costruire una più generica e confusa cornice di cultura della cancellazione, è necessario partire dal 2015. Fu l’annus horribilis della cosiddetta alt-right, comunità “memetica” di estrema destra la cui attività di produzione di contenuti online avrebbe poi svolto un ruolo nell’elezione di Donald Trump dell’anno seguente.
Angela Nagle (2015) in Kill All Normies mostra i legami tra l’imageboard 4chan e l’espressione di ideologie estremiste come il neonazismo [2]. Se le forme più estreme di queste ideologie trovano uno spazio di espressione privilegiato in zone ‘periferiche’ del web come 4chan, in spazi più mainstream come quello di Twitter si può osservare come si distinguessero già community caratterizzate dall’azione dei cosiddetti troll.
Questi ultimi, attraverso profili più o meno anonimi, contribuiscono alla costruzione identitaria dell’alt-right attraverso episodi di hate speech e cyber-bullismo di gruppo contro quelle che sono riconosciute “minoranze”, quindi tramite discorsi anti-femministi e conservatori. È proprio nel 2016 che Twitter inizia a promuovere l’espulsione [3] degli account alt-right in quanto violanti le policy della piattaforma.
Momento fondativo rispetto alla nascita di queste comunità online è l’episodio del #gamergate. La campagna di demonizzazione indirizzata verso alcune personalità femminili del mondo videoludico nordamericano nasce nell’estate del 2014, dapprima su forum come Reddit ed il succitato 4chan. Da qui si svilupperanno, poi su Twitter, thread radunati sotto l’omonimo hashtag.
Doxxing e shitstorm
Per quanto possa sembrare un episodio che interessa soltanto una nicchia digitale, per certi versi, con la stagione del gamergate si crea un precedente storico importante per la codificazione di pratiche violente online fino ad allora poco grammaticalizzate. Come per esempio il doxxing ovvero la diffusione anonima di informazioni sensibili (dati anagrafici, indirizzo di residenza, mail privata di una personalità) con finalità intimidatorie.
Analogamente, si parla di shitstorm per descrivere la partecipazione in massa – spesso organizzata – ad una discussione o ad un post di qualcuno con insulti, o comunque con finalità derisorie.
Grammaticalizzazione di pratiche violente online
Con “grammaticalizzazione” si intende la progressiva associazione di una pratica culturale ad un codice semiotico, che ne consente una riconoscibilità e una replicabilità all’interno della semiosfera [4]. Secondo il semiotico russo, infatti la cultura si organizza attraverso delle sfere di produzione testuale, caratterizzate dalla presenza di diversi linguaggi, i cui significati vengono poi compresi dalle sfere adiacenti attraverso pratiche di traduzione che ne consentono una lettura, interpretazione, e quindi nuova produzione.
Al centro di queste semiosfere si trovano testi fortemente grammaticalizzati – ossia strutturati in maniera particolarmente prescrittiva dai codici che vi soggiacciono – che si costituiscono così come modelli per nuove produzioni di testi.
Pratiche di intimidazione
Questo tipo di pratiche di intimidazione online assomigliano a episodi – con una precisa tradizione storica – organizzati di attacco verso figure pubbliche su base politica.
Attorno a questi episodi – di natura discriminatoria spesso misogina, razzista o omotransfobica – si avverte all’interno delle comunità colpite la necessità di organizzare forme di resistenza.
Emergono le politiche identitarie
Dal momento in cui Twitter stesso non riesce a svolgere un adeguato lavoro di moderazione dei contenuti che ospita, alcuni utenti si organizzano dal basso per appaltare il mancato lavoro di policing, ovvero per provare a neutralizzare i comportamenti violenti e rendere lo spazio virtuale più abitabile per quelle identità collettive che più spesso vengono prese di mira.
Ci si ritrova, in questo caso, all’interno del quadro dell’identity politcs (Heyes, C. 2020). Seguendo la definizione della Stanford Encylopedia of Philosophy, la politica identitaria significa un’ampia gamma di attività politiche e fonda la teorizzazione nelle esperienze condivise di ingiustizia subita da membri di certi gruppi sociali. Invece di organizzarsi esclusivamente intorno a sistemi di credenze, manifesti programmatici o appartenenza a partiti, le formazioni di identità politiche tipicamente aiutano a rendere sicura la libertà politica di specifici sostenitori marginalizzati nel loro contesto più ampio [5].
La stagione del #MeToo
Queste comunità online svolgono un lavoro di policing agito sulle piattaforme. Lo spiega la studiosa dei media Lisa Nakamura, esplorando la call out culture come venture community management [6].
Questo tipo di pratiche di moderazione della comunità dal basso prende il nome da “to call out” (che a livello letterario possiamo tradurre come “fare appello”, segnalare). La pratica di fare appello si riferisce al concetto di accountability, come rivendicazione di un principio di imputabilità di fronte a determinati post o commenti che vengono ritenuti discriminatori, segnalandoli a un tempo alla piattaforma e alla comunità di riferimento.
Nakamura, dalla sua prospettiva intersezionale, interpreta il call-out come un lavoro di cura non retribuito, svolto da determinati attori sociali a profitto (anche economico) della piattaforma. Un lavoro che definisce indesiderato (“unwanted”, ivi), a dispetto di chi considera la pratica del call-out – che molto spesso consiste effettivamente sulla moderazione linguistica – una pedanteria, se non la manifestazione di un atteggiamento censorio. Così si spiegano infatti le invocazioni della libertà di espressione di cui la direzione trumpiana e gran parte del GOP si sono fatte da subito.
A distanza di qualche anno, Duchi (2019) osserva una progressiva popolarizzazione di questa pratica di segnalazione che a Nakamura appariva, mentre scriveva, per lo più disincentivata. In questo senso, è significativo sottolineare lo scoppio, nel 2017, della stagione del #MeToo. La denuncia pubblica su Twitter. Le vittime si fanno vicendevolmente coraggio in una catena di prese di parola (letteralmente: “anch’io” o “anche a me”), del sistema di abusi sessuali perpetrato dagli uomini di potere dello star system hollywoodiano – a partire dal produttore Harvey Weinstein, passando per altri casi che hanno raggiunto una portata di scala globale, come quello dell’attore Kevin Spacey.
Dalla dimensione social al mainstream
Il #MeToo ha rappresentato uno scandalo internazionale. Si può osservare come le pratiche pubbliche del call-out escano in questo caso, per la prima volta, dalla dimensione mediale specifica delle piattaforme social e facciano breccia nel discorso pubblico mainstream e globale.
Quando si parla di #MeToo, ci si sta infatti riferendo ad un movimento che nasce come hashtag su Twitter. Prende poi progressivamente spazio in tutti gli ambiti della cultura. Ma anche nel lavoro e nelle istituzioni. È un’occasione in cui diventano tangibili presso la società civile le potenzialità non solo di fuoriuscita e popolarizzazione delle pratiche specifiche agli ambienti digitali, ma anche di una loro istituzionalizzazione.
Così, irrobustita dalla stagione del #MeToo, si viene così a costituire una più ampia “call-out culture” come oggetto discorsivo che può essere usato tanto dagli attivisti progressisti quanto dai detrattori conservatori.
Se si legge questa pratica online all’interno della cornice di senso dell’economia della reputazione dei social media, è facile comprenderne il successo. I singoli utenti potrebbero essere più interessati a beneficiare di un ritorno di immagine a partire dall’occasione di manifestare il proprio valore morale, affermando al contempo la propria appartenenza ad un’identità collettiva – il cosiddetto virtue signalling – che a spendersi effettivamente per una causa sociale.
Questa nozione di economia della reputazione permette, tra le altre cose, di spiegare la migrazione dei codici delle comunità online ai reparti di diversity management in ambito aziendale.
Perdere follower su Instagram o Twitter significa un’immediata perdita di reputation, attenzione e dunque fatturato [7].
Slacktivism
Per questo tali pratiche di attivismo online sono spesso tacciate di attivismo performativo, o slacktivism, una forma di attivismo che non ha alcun effetto trasformativo, se non un ritorno di immagine, moneta principale di una dimensione di simulacri, sulla realtà e non richiede un effettivo lavoro da parte di chi lo promuove.
Tuttavia, se si adotta una prospettiva semiotica non ci si interroga sulla sfera delle intenzioni che motivano i processi di produzione testuale, e diventa estremamente meno interessante cercare di determinare quanto l’adesione ad una determinata causa sia un gesto privato; sarà più interessante osservare le implicazione delle affordances della piattaforma nel conferire a una battaglia per la giustizia sociale una forma specifica.
Il Twitter mob
Al contempo, è necessario segnalare come la pratica del call-out, proprio per com’è costituita nella sua natura mediale, possa a sua volta finire per ribaltarsi in una pratica violenta. La partecipazione numerosa ad una discussione attorno ad un hashtag con post, commenti e retweet finisce per creare l’impressione di una massa inferocita. La cosiddetta “Twitter mob” si accanisce, in nome della giustizia sociale, contro l’espressione di un soggetto.
In una dimensione di collasso del contesto [8], qualsiasi enunciato può a tutti gli effetti essere decontestualizzato, allestendo un tribunale popolare che dà luogo ad una forma di “online public shaming” paradossalmente accostabile, nelle ricadute, alle shitstorm proprie invece delle comunità alt-right, cui si è fatto riferimento in precedenza.
Dal call-out al canceling
Non a caso, è proprio questo aspetto a costituire l’accusa principale che si muoverà contro quella che viene definita la cancel culture: gli “attivisti che sono andati troppo oltre” [9].
Per comprendere meglio il rapporto tra le diverse forme di codificazione culturale delle pratiche – che seguono, secondo la lezione della semiotica, modelli di costruzione polemica delle posizioni – manca un anello di congiunzione: l’esposizione di un’ulteriore pratica online che prende il nome di canceling. Essa verrà accostata al lessema del call-out fino a sostituirvisi, nell’uso denotativo che se n’è fatto all’interno dell’opinione pubblica. Ciò succede nel discorso pubblico italiano. Infatti nel nostro Paese si è difficilmente impiegato il termine “call-out”.
Il canceling in una prospettiva transmediale
Se si osservano le intersezioni tra diversi ambienti mediali, all’interno di un contesto di cultura convergente [10], si può notare come il termine canceling sia migrato dalla dimensione televisiva al contesto specifico dei social media.
Secondo la reporter Aja Romano, la pratica del canceling si diffonde in seno alle comunità del Black Twitter durante il 2015. Lo fa attraverso meme che si riferiscono ad una puntata di un reality show americano. In questo contesto, una concorrente, per rispondere ad un episodio di sessismo, si riferisce ad un altro con l’espressione “You are canceled!”.
La cancel culture viene dunque vista come un’estensione della call-out culture [11].
Esiste una continuità tra la pratica del canceling agita dalla comunità afroamericana su Twitter, ed una storia di opposizione articolata dai movimenti politici. Si fa riferimento qui ai civil rights boycotts degli anni Cinquanta e Sessanta. All’interno di questo frame, l’attività di boicottaggio viene interpretata come un rifiuto di partecipare. Come l’unico strumento di opposizione individuale – e collettivamente organizzato – di fronte alla constatazione di un problema sistematico quale è quello
razziale.
La logica della resistenza passiva – propria dell’esperienza politica degli anni Sessanta – del “non ho potere, se non quello di ignorare” si fa resistenza attiva nella sua collettivizzazione.
Il boicottaggio
Appare però immediata una discontinuità tra le varie pratiche online. Come già accennato, l’obiettivo del call-out sarebbe quello di fare appello, convocare l’imputabilità – o accountability – del soggetto di fronte ad i suoi errori. Avrebbe quindi uno scopo pedagogico.
Il canceling invece si contraddistingue come una forma di protesta e di scontro. Consisterebbe quindi in un tentativo di boicottaggio. Due pratiche, pur avendo una differente origine e morfologia, finiscono per associarsi, una volta imbracciate da una medesima comunità.
Educazione e conflitto sono infatti due corni di una stessa attività di policing, agita da parte di soggettività collettive, all’interno di uno stesso spazio mediale in questi stessi anni. Sono le produzioni di senso di identità politiche iper-codificate, grammaticalizzate, che esercitano un lavoro di cura o un’attività di protesta – forse due facce di una stessa medaglia, non dissociabili fino in fondo – all’interno di Twitter, nella seconda metà degli anni Dieci.
Il caso JK Rowling
Un esempio che può favorire l’intelligibilità del canceling – nella sua associazione con il call-out, e nella successiva risemantizzazione dell’evento come caso di cancel culture – è quanto avvenuto alla celebre scrittrice JK Rowling, tra il 2019 ed il 2021.
L’inventrice di Harry Potter sarebbe stata “cancellata” per essere entrata in polemica con la comunità LGBTQ+ su Twitter, in seguito alle
svariate occasioni in cui avrebbe manifestato, con i suoi post, delle opinioni percepite come transfobiche. O più precisamente, avrebbe esplicitato la sua collocazione nel cosiddetto femminismo TERF, la corrente radicale che esclude le donne trans dalle rivendicazioni proprie del femminismo, insistendo su una visione del genere come strettamente dipendente dal sesso assegnato alla nascita.
Queste posizioni, che vengono considerate come casi di hate speech, dal momento che negano la validità dell’esperienza delle persone appartenenti a una categoria marginalizzata, finiscono inevitabilmente per diventare oggetto di discussione. Si innesca un botta e risposta con alcuni account, che non si conclude in maniera pacifica: JK Rowling viene segnalata alla comunità online per essere transfobica (il momento del call-out).
La contestazione, radunata dall’hashtag che diviene trending topic su Twitter, si inasprisce. Fioccano commenti d’odio. Vengono postati video di fan delusi che bruciano i propri libri di Harry Potter. E si chiede ai famosi attori che hanno interpretato i personaggi della saga di dissociarsi pubblicamente – sulla piattaforma – dalle dichiarazioni di Rowling. Scatta così il boicottaggio della scrittrice (il momento del canceling).
La lettera dei 153 intellettuali
La polemica compie un salto di popolarità circa un mese dopo, quando viene pubblicato su Harper’s Magazine un manifesto firmato da 153 “intellettuali”, col titolo “A Letter on Justice and Open Debate“. L’iniziativa è sostenuta da personalità pubbliche del calibro di Noam Chomsky, Margaret Atwood e la stessa Rowling. E diventa celebre sui quotidiani internazionali ed italiani come “la lettera contro la cancel culture”.
JK Rowling denuncia la sofferenza subita per questa esperienza di boicottaggio, condita da minacce e insulti; al tempo stesso rivendica la propria libertà di pensiero e di opinione – che, per la comunità che l’ha contestata, continua ad essere la rivendicazione di una libertà di discriminare.
Definizione di cancel culture
Si è finora cercato di ricontestualizzare l’emersione di queste pratiche digitali, che saranno inglobate dal caotico significante “cancel culture”. All’interno del dibattito pubblico, soprattutto nel contesto italiano, si è sentito parlare di cancel culture come tentativo di “cancellare il passato”: la storia, la memoria, le tradizioni (Figura 1).
Come si evince dal caso Rowling, e come nota anche Raffaele Alberto Ventura [12], un comportamento percepito come sessista o razzista ad esempio, sui social, tenderà a non passare più inosservato – come poteva accadere fino a pochi anni prima, in determinati contesti pubblici. Questo è indice di una sensibilità mutata. Ed il mutamento si rende particolarmente visibile nell’acceleratore semiotico delle piattaforme social.
Accountability, boicottaggio, cancellazione
Per spiegare l’allacciamento semantico della segnalazione (richiesta di
accountability) e del boicottaggio, con quello della cancellazione, abbiamo formulato un’ipotesi provocatoria. L’imprevedibilità delle logiche enciclopediche avrebbe questa volta mescolato le carte in gioco.
Il termine “canceling” è sorto all’interno di una dinamica transmediale: “You are canceled!”. L’espressione potrebbe benissimo essere tradotto con “Per me è finita!”. Oppure: non voglio più saperne niente, non voglio più avere niente a che fare con te.
In questo senso “cancellare” significherebbe semplicemente “chiudere con qualcuno o qualcosa”: unfolloware. E quindi sottoporre a deplatforming [13], boicottare, fare terra bruciata. Questo suo aspetto semantico favorisce un’associazione dell’espressione alla pratica del call-out, finendo progressivamente per rimpiazzarla e divenire riferimento predominante. Il tutto avviene con la collaborazione dell’appropriazione egemonica da parte dei media conservatori americani.
L’abbattimento di statue, simboli neocoloniali
Uno dei casi in cui emerge maggiormente questo slittamento semantico è quello dell’abbattimento di statue.Le statue abbattute presentano simboli considerati neocoloniali. L’azione simbolica di smantellamento della statua lascia spazio all’interpretazione di una cultura della cancellazione che vuole, in qualche maniera, cancellare la storia.
Ma, come si è provato a dimostrare, far ricadere questa eterogeneità di pratiche sotto una stessa etichetta rischia di omologare gesti simbolici con connotazioni molto diverse.
Inoltre, in questi casi, la cancellazione della storia appare completamente fuori luogo. Anche il tentativo di spiegare queste pratiche attraverso i riferimenti alla damnatio memoriae, come pratica di riscrittura sistematica delle fonti, rientra negli stessi processi di traduzione “aberrante”.
Se si considera infatti lo spazio come un ambiente significante in cui l’architettura svolge una funzione simbolica [14], si vedrà come l’erezione di monumenti sia il prodotto di scelte che rimandano a quadri memoriali specifici, e non a una presunta storia universale. In quanto tali, fungono da campo di forza per rivendicazioni politiche. Infatti, nell’abbattere una statua, piuttosto che voler cancellare la storia, si sta cercando di contestare la scelta politica di selezionare una porzione della storia a simbolo protagonista dello spazio pubblico. Senza considerare il fatto che, in termini semiotici, cancellare un segno è qualcosa di estremamente problematico. Ed ogni tentativo di cancellazione va letto come una nuova produzione di senso [15].
È dunque possibile ora tentare, a ritroso, di ricostruire gli snodi connotativi e traduttivi. Quelli che hanno portato a questa omologazione di diverse pratiche all’interno della stessa, caotica, etichetta. E con essi tracciare l’operazione di risemantizzazione della pratica del canceling da parte dei mainstream media americani conservatori.
L’intervento della destra trumpiana
È infatti in questo ambiente mediale ideologicamente connotato che il concetto di cancel culture viene esplicitamente armato dalla destra trumpiana. Lo stesso Trump avrebbe ad esempio asserito, in occasione della convention repubblicana del 2020: “L’obiettivo della cancel culture è far vivere i ‘decent Americans’ nella paura di essere bruciati, espulsi, svergognati, umiliati e cacciati dalla società che conosciamo”.
Come riporta Romano, chi vota Repubblicano dice di sapere cosa sia la “cancel culture” in misura doppia rispetto ai Democratici e la paragona a violente rivolte politiche.
Alla del 2020, almeno un terzo degli speaker ha fatto della cancel culture un punto centrale del proprio intervento. Si parla di cancellare la storia, ammutolire i cittadini e violare il libero scambio di idee, pensieri e parole.
Woke mob
Nella primavera del 2021 alla CPAC (Conservative Political Action Conference), intitolata proprio “America Uncanceled”, si stabilizza ufficialmente la contro-narrazione della cancel culture come frame conservatore.
L’osservatrice del New York Times, Kristi Noem, nota come questa sia il
nuovo cavallo di battaglia di Trump – assieme al concetto di “woke mob” – dopo quello di “fake news”, tormentone agitato nella campagna elettorale del 2016.
Aja Romano osserva invece come si tratti di un’operazione egemonica di panico morale, in continuità con le strategie di gestione della discussione politica su temi quali la questione del politicamente corretto già a partire dagli anni Novanta [16], nel contesto anglo-americano.
Come ha notato la sociolinguista Deborah Cameron [17] nella sua esposizione del concetto di igiene verbale, si tratterebbe di una strategia di ridicolizzazione e svilimento delle proposte da sinistra sulla moderazione del linguaggio e sulla rappresentazione delle diversità, che manifesta le sue radici nei differenti precedenti storici che hanno costituito il frame interpretativo della cosiddetta “loony left”: la sinistra strampalata, che amplifica questioni di natura semio-linguistica allontanandosi dal senso comune e dai “veri problemi della gente”.
Conclusioni
Emergono chiaramente gli effetti dei processi traduttivi intorno ai fenomeni all’interno di contesti mediali ideologicamente polarizzati. Nella ricontestualizzazione proposta emerge una forma quasi sclerotizzata della struttura polemica che Lotman individua nell’organizzazione dei testi di una cultura.
A partire dal gamergate emergono pratiche di resistenza come quella del call-out. Ad essa si affiancano dinamiche di boicottaggio – con precise derivazioni storiche – che vengono tradotte di contesto mediale in contesto mediale, fino ad assumere diverse forme e connotazioni nel discorso pubblico. Una volta acquisita una denominazione e una riconoscibilità, queste pratiche possono quindi essere interpretate da parte di diverse comunità in quanto unico oggetto discorsivo, un significante vuoto che è campo di forze per diverse strategie
identitarie di legittimazione politica in conflitto tra loro.
Si vuole quindi porre l’attenzione sul fatto che un altro dei motivi che sostanziano la formazione discorsiva dell’oggetto cancel culture, quanto meno all’interno del dibattito pubblico italiano, è una ragione profondamente mediale.
Se nel mainstream si è in grado di indicare una serie di pratiche eterogenee e diverse tra loro come appartenenti ad un unico quadro significante, è perché nelle pratiche traduttive si sono persi degli elementi di decodifica che ne consentirebbero un’interpretazione felice [18]. Un’interpretazione adeguata ai loro elementi costitutivi, co-testuali e circostanziali.
Lo scenario italiano
Nel dibattito italiano sulla cancel culture infatti non si fa riferimento al gamergate. O alle specificità dei diversi codici subculturali appartenenti al mondo digitale. A questo, si aggiunge un filo conduttore – che ha precise ragioni storiche – tra i media americani e quelli italiani. Questi ultimi, per adeguarsi ai prerequisiti sensazionalistici della click economy, si ritrovano a importare notizie scorrette. O inquadrate in maniera fuorviante, come il caso della notizia del bacio di Biancaneve.
Si tratta quindi di un medesimo problema di traduzione, per dirla in termini semiotici. Sia per quanto riguarda i contenuti dell’informazione, che vengono così decontestualizzati nell’importazione presso la semiosfera italiana, sia per quanto riguarda il modello economico della comunicazione informativa digitalizzata, improntata al sensazionalismo e al clickbaiting.
Il quadro discorsivo della cancel culture viene quindi attivato da iniziative potenzialmente scandalose, che una volta riprese si prestano a fare engagement su social come Facebook (più usato in Italia rispetto a Twitter), e che vengono effettivamente considerate come scandalose perché collocate in una dimensione di conflitto socioculturale.
Quest’ultimo si rivela essere un più profondo conflitto tra codici semiotici: è la reazione indignata ad una proposta di senso (magari esasperata, e gonfiata ad arte nella costruzione della notizia) che non si riesce a decodificare, ad interpretare se non in termini polemici; nel migliore dei casi come un’assurdità, nel peggiore come un apocalittico programma di autodistruzione della cultura occidentale di cui siamo vittime.
La volontà politica
Ogni invenzione all’interno del campo della cultura viene descritta da Lotman come un’esplosione [19], il cui riverbero viaggia a diverse velocità all’interno delle semiosfere. E subisce continui processi traduttivi.
Le identità che animano le pratiche del call-out e del canceling pongono una critica ad una tradizione consolidata e a sua volta grammaticalizzata, riconosciuta come imperialista e sessista. Si tratta di saperi che, rispetto alla tradizione cui si rivolgono, hanno una storia recente. Il campo discorsivo dei gender studies emerge ad esempio appena cinquant’anni fa.
Questi saperi presentano a loro volta un alto grado di grammaticalizzazione, soggetto a nuovi codici. Anche queste dinamiche traduttive rientrano nel modello polemico di organizzazione della cultura, dove le diverse semiosfere – caratterizzate da diversi codici – presentano diversi gradi di permeabilità. Da qui deriva la difficoltà ad assorbire queste proposte di senso. La difficoltà di permettere loro di muovere verso il centro della semiosfera – sfondare, in un certo senso, nel mainstream.
Adottando questa prospettiva, un fraintendimento basato su una discrepanza di codici sembra perfettamente plausibile. Nella stessa dimensione polemica di conflitti e negoziazioni, è dunque altrettanto plausibile considerare come strategica la volontà politica di farlo di proposito per opporvisi. E, di conseguenza, sabotarle. Ma, di nuovo, lo spazio dell’intenzione rimane al di fuori dello sguardo semiotico, e questa può rimanere unicamente un’ipotesi critica.
Bibliografia
- Jenkins, H. (2006): Convergence culture: where old and new media collide, New York, New York University Press, trad.it Cultura convergente, Apogeo editore, Milano, 2014. ↑
- Sempre da lì nasce infatti la fantasia di complotto conosciuta come QAnon, che si è svelata al mondo con l’assalto del Campiglio nel gennaio 2021. ↑
- “When Twitter conducted a so-called ‘purge’ of alt-right accounts in 2016”, pag. 215, Rogers 2020. ↑
- Lotman J. M., 1975: La semiosfera, l’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, a cura di Salvestroni e Sedda, La Nave di Teseo, Milano, 2022. ↑
- Stanford Encylopedia of Philosophy. ↑
- NAKAMURA, L. (2015): “The Unwanted Labour of Social Media: Women of Colour Call Out Culture As Venture Community Management” in New Formations, 86, pp.106-112. ↑
- LOVINK, G. (2022): Stuck on the platform, Valiz, Amsterdam (pp.147-148). ↑
- DAVIS, J.L., JURGENSON, N. (2014): “Context collapse: theorizing context collusions and collisions”, Information, Communication & Society, 17:4, 476-485, DOI: 10.1080/1369118X.2014.888458. ↑
- “Activists have gone too far” è l’adagio popolare con cui, negli States, si cerca di infantilizzare la sensiblità politica dell’attivismo giovanile sui social. ↑
- JENKINS, H. (2006): Convergence culture: where old and new media collide, New York, New York University
Press, trad.it Cultura convergente, Apogeo editore, Milano, 2014. ↑ - “Cancel culture can be seen as an extension of call-out culture: the natural escalation from pointing out a problem to calling for the head of the person who caused it”. ↑
- VENTURA, R.A. (2022): “Dieci tesi sul politicamente corretto Nuovi codici e nuovi conflitti” in in AA. VV., Non si può più dire niente?, UTET, Torino. ↑
- ROGERS, R. (2020): “Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative Social media”, European Journal of Communication, 2020, Vol. 35(3) 213–229. ↑
- Eco 1975, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano; Violi 2014, Paesaggi della memoria, Bompiani, Milano. ↑
- LORUSSO, A.M. (2021): “Cancellare, tra segni e codici”, Filosofi(e) semiotiche, pp. 1-7.. ↑
- FRIEDMAN, J. (2018): PC Worlds. Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony, Berghahn Books, New York, trad. it Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime, Meltemi, Milano, 2018. ↑
- CAMERON, D. (1995): Verbal Hygiene. The politics of language, Routledge, London-New York. ↑
- ECO, U. (1979): Lector in fabula, Bompiani, Milano. ↑
- LOTMAN, J.M. 8 (1992): Kultura i vzryv, Gnosis, Moskva, (trad. it. La cultura e l’esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Feltrinelli, Milano, 1993). ↑